
Valdaveto.net
Val d'Aveto official website
Valdaveto.net > Articoli e ricerche di carattere storico > Il ducatone
Il ducatone
Capitolo estratto da 'La Val d'Aveto - Frammenti di storia dal Medioevo al XVIII secolo', tipografia Emiliani, Rapallo 1998
Confortati dalla più antica e provata testimonianza in nostro possesso, possiamo far risalire agli inizi del XII secolo la documentata
presenza in Val d'Aveto di monetazione metallica. Si tratta della pergamena datata 30 marzo 1103, nella quale il priore Alberto,
fondatore del monastero benedettino di Villacella, offre alla "casa madre" il censo
annuale di "venti soldi di buona moneta nuova di Pavia".
È tuttavia quasi certo che, veicolate dalla stessa matrice monastica, tracce antesignane di "brunetti pavesi" siano arrivate ad
Alpepiana sin dall'ottavo secolo. Ma è altrettanto indubitabile che la circolazione monetaria nell'alto medioevo valdavetano doveva
necessariamente essere molto ridotta.
La società curtense era a tal punto primordialmente autarchica, da potersi agevolmente consentire
il ricorso ad un ordinamento monetario quasi astratto, inteso come unità di comparazione
cui riferirsi per quantificare il valore dei prodotti e prestazioni.
Solo verso la metà del XII secolo, con l'avvento dell'epoca feudale e la conseguente istituzione dei pedaggi daziali (secolo XIII),
l'economia monetaria nella valle diventerà significativa.
In quel periodo, molti mulattieri e mercanti (soprattutto toscani), per valicare l'Appennino attraverso l'arteria del Cifalco, dovevano obbligatoriamente attraversare il territorio del marchesato di Santo Stefano.
Il derivante pedaggio, imposto dalle signorie, permetterà
alla Camera feudale di disporre di una insostituibile, anche se modesta, rendita monetaria.
E saranno monete bizantine, arabe, lucchesi,
fiorentine, ossia la medesima "valuta straniera" utilizzata per oltre due secoli dalla stessa Repubblica genovese per operare su
tutti i mercati.
Solamente nel 1139, un diploma imperiale concede a Genova la facoltà di
battere moneta. E a dimostrazione di quanto se ne avvertisse l'esigenza, dal conio uscirà immediatamente e in grande quantità il
primo "denaro iti mistura", composto per due terzi da rame e per un terzo d'argento.
Qualche anno dopo verrà
coniata la prima moneta d'argento, del valore di quattro denari, denominata il "grosso".
Ma la spietata concorrenza di
Venezia e Firenze sui mercati obbligherà la zecca genovese ad orientarsi verso una monetazione aurea.
Nasceranno così in rapida sequenza V"ottavino",il "genovino", la "quartarola d'oro",
lo "scudo".
Nel 1488, a fronte di una impressionante varietà e quantità di monete coniate, il Senato avverte l'improcastinabile necessità
di creare un'unità fondamentale di conto a cui rapportare il valore legale imposto alle più svariate coniazioni.
Allo
scopo, si conviene che dodici denari formino un soldo e che venti soldi costituiscano una lira genovese.
In pratica il primogenito "denaro
in mistura" era la duecentoquarantesima parte di una lira.
Altro esempio: se il valore legale del "grosso" d'argento
era di quattro denari, è del tutto palese che ne occorrevano sessanta per formare una lira.
La questione, anche per mio
demerito, può apparire intricata: in realtà era molto semplice.
Esemplificando possiamo, per analogia, comparare la lira genovese
all'attuale ECU, ossia ad un comune denominatore in grado di assicurare un omogeneo punto di riferimento per valorizzare
valute differenti.
Dopo questo sintetico ma ritengo utile proemio, la totale imperizia dello scrivente, sommata alla vastità del tema,
mi consigliano un subitaneo restringimento del nostro interesse allo specifico
argomento di questo capitolo, ovvero la monetazione marchionale in Val d'Aveto.
La facoltà di "battere moneta" del
nostro piccolo stato feudale risale all'anno 1249. Diritto accordato all'allora feudatario Morello II Malaspina dall'Imperatore Federico II.
La stessa prestigiosa concessione sarà rinnovata a Gian Luigi Fieschi dall'imperatore Carlo V nel 1543.
Ma come accade spesso, alla
titolarità di un diritto non necessariamente corrisponde la fruibilità automatica dello stesso.
Le difficoltà e i
costi dell'impiantare una zecca finivano per ridurre il privilegio di coniare denaro ad una formale espressione di potere, certo più
adatta a placare le vanità dell'apparire piuttosto che a soddisfare le reali esigenze dell'essere.
Non esistono prove documentate
dell'esigenza di monete di Santo Stefano relative alle dominazioni dei Malaspina e dei Fieschi.
Non solo, ma lo "scrutinio della rendita del marchesato di Santo Steffano d'Avato fatto a tepo del Ecc.mo conte del Fiesco", nel
computare le rendite fa esplicito riferimento alla "moneta di Genova", escludendo di fatto l'esistenza di una
monetazione locale.
Ben altra tradizione di conio riuscirà a vantare la famiglia Doria.
Nel 1594 inizia a produrre la
prima zecca doriana in quel di Loano, seguita da quella di Torriglia nel 1665.
Più recenti quelle del Laccio, di Montebruno, Carrega,
Rovegno, Garbagna, Grondona. Bisogna premettere che l'attività di queste particolari officine era spesso più indirizzata alla
realizzazione dei sigilli e delle medaglie dei principi Doria che non alla coniatura di denaro vero e proprio.
Ma è innegabile che il
diritto di "battere moneta" trovò nell'illustre famiglia genovese l'espressione più alta e grandiosa.
Dall'archivio
Doria-Pamphili risulta che, il 15 settembre 1668, Bartolomeo Pareto di Lorenzo otteneva dalla principessa Lomellini, vedova del feudatario di
Santo Stefano, Andrea III Doria, il permesso di costruire una zecca nel borgo.
A conferma dell'avvenuta attuazione del progetto, esiste una
ricevuta del 7 marzo 1683, per "400 pezzi" che il Pareto aveva pagato in anticipazione all'agente del principe Gian Andrea
III.
Lo storico doriano Agostino Olivieri ci informa laconicamente che "la locazione durò breve
tempo". Evidentemente l'intraprendente valdavetano dovette scontrarsi con tali e tante difficoltà da essere costretto a
desistere.
Per rievocare degnamente l'acquisizione del feudo di Santo Stefano, avvenuta nel 1592, il principe Gian Andrea I
commissionò alla zecca di Loano la coniazione di una medaglia celebrativa.
La scelta cadde felicemente sul ducatone, superba
sintesi di moneta
decorativa, di corso legale su tutto il territorio della Repubblica.
Il ducatone era un grosso coniato d'argento, del diametro di circa
4,5 centimetri, a cui le gride genovesi del 1602, 1606, 1616 attribuivano il peso di 1 oncia, 5 denari, 8 grani, 7 decimi (circa 32 grammi) e un
valore legale di 3 lire genovesi, 15 soldi, 9 denari.
Nelle suddette gride si accenna anche all'esistenza di "spezzati",ossia
sottomultipli della stessa moneta, ma a conferma della loro rarità a Genova non se ne trova alcuno.
La stessa diffusione del
ducatone fu abbastanza limitata; il rapporto dimensioni - peso - valore legale pendeva inevitabilmente a favore dello "scudo d'oro", molto più leggero (pesava circa 3 grammi) e con un valore legale più elevato (4 lire e 10 soldi).
Questa mia considerazione appoggia su un dato oggettivo: dalla zecca della repubblica furono coniati, nel 1601, circa 54.000 ducatoni, contro i 243.000 scudi d'oro impressi nello stesso anno.
Il ducatone di Santo Stefano, voluto da Gian Andrea I e di cui l'Università di Genova conserva un esemplare (seppur molto corroso), aveva un peso pari a 1 oncia, 4 denari, 7 grani (circa 31 grammi), quindi leggermente inferiore a quello della Repubblica, ma di quest'ultimo conservava lo stesso valore legale.
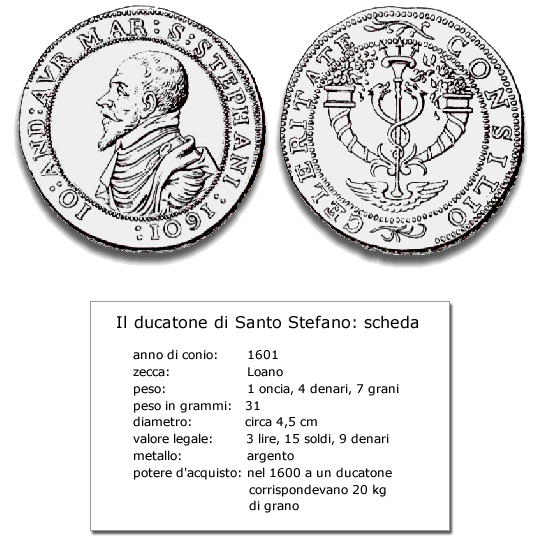
Come appare evidente nella riproduzione ingrandita allegata,
si trattava di una bellissima moneta commemorativa.
Sul "diritto" l'effigie del principe stesso era circondata dall'epigrafe
"Gian Andrea Doria marchese di Santo Stefano 1601".
Sul "rovescio" il caduceo, simbolo di pace, era incorniciato
dal motto "celeritate consilio", solenne esaltazione di quel tempismo politico di cui indubbiamente il Doria poteva
fregiarsi a pieno titolo.
A questo punto credo si debba tentare di rispondere ad una domanda, che
lo stesso scrivente si è posto più volte: quale era il reale potere d'acquisto del ducatone?
Agli inizi del XVII secolo, con un
ducatone si potevano comprare circa 20 Kg. di grano. Verso il 1650, i manovali di Santo Stefano, che trasportavano il materiale edile necessario
per la manutenzione del tetto del castello, ricevevano dal Doria una paga giornaliera di sei soldi.
Occorrevano dunque tredici giornate di
lavoro per ottenere un ducatone. Ma il raffronto più incredibile è quello tra l'altissimo prezzo di mercato del grano contro il
bassissimo valore attribuito ad una giornata di lavoro.
Infatti, comparando i due dati, scopriamo che la paga giornaliera di un manovale
corrispondeva a meno di due chilogrammi di grano.
È del tutto ovvio che la quotazione del cereali risentiva in maniera determinante
delle spaventose carestie che assediavano perennemente le città rivierasche.
Mentre
per il lavoro a giornata la situazione era esattamente opposta: all'assoluta necessità di lavorare si contrapponeva una scarsissima
richiesta di prestazioni d'opera, con l'inevitabile conseguenza di un salario molto basso.
In buona sostanza, questa condizione paradossale
era totalmente imputabile all'implacabile e, per molti aspetti, aberrante legge della domanda e dell'offerta.
Links
Pagina pubblicata il 2 gennaio 2009, letta 5122 volte
Per esprimere un commento su questo articolo si prega di contattare la redazione via e-mail
